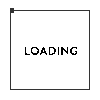Riscoprire Jeff Buckley
Un giovane devoto alla musica e alle sue storie, ai suoi colori più diversi, riesce a pubblicare un album e della musica si trova così a cambiare la storia. Con un solo album influenza per sempre chiunque prenda in mano un microfono dopo di lui.
Non è la trama di un film facile alle esagerazioni, è la storia tragica e straordinaria dell’ultima grande voce-icona che abbiamo avuto l’onore di conoscere.
Basti pensare ai nomi di chi, all’uscita dell’album” Grace”, sentì il bisogno di complimentarsi con il giovane debuttante dal cognome imponente: David Bowie, Jimmy Page e Robert Plant. Mentre un altro signore, un certo Bob Dylan, segnalava le sue sensazionali doti d’autore.
Jeff Buckley visse i suoi primi anni come Scottie Moorhead, con una madre che gli insegnava ad armonizzare cantando in casa ed un patrigno che lo introduceva ai grandi nomi del rock – Hendrix, gli Who, i Pink Floyd e soprattutto quei Led Zeppelin che più di tutti lo avrebbero illuminato e guidato. Il suo certificato di nascita gli avrebbe presto rivelato che quella musica allora nei suoi decenni più illustri – i Sessanta e i Settanta che “Scottie” assorbiva attento – lui ce l’aveva letteralmente nel sangue. Il cognome, quello vero, era Buckley, e il padre lontano era l’inarrivabile Tim.
La tragedia bussò alla porta dei Buckley nel ’75, portandosi via l’appena ventottenne Tim con un’overdose. Fu allora che Jeff decise di riappropriarsi del cognome.
La musica chiamava insistente: a cinque anni aveva cominciato a suonare la chitarra, e a tredici impugnò la sua prima elettrica. Il richiamo della Musa parlava lingue diverse, e nel 1990 Jeff scoprì i canti sacri dei Sufi (in particolar modo quella di Nusrat Fateh Ali Khan), un incontro destinato ad influenzare indelebilmente il suo
canto.
Un altro incontro decisivo avvenne l’anno successivo, quando conobbe l’eclettico chitarrista Gary Lucas. Cominciarono subito a lavorare insieme, dividendosi tra cover imponenti e sorprendenti inediti – così, nel giro di pochi mesi, “Grace” e “Mojo Pin” erano nate.
Altri pezzi erano già stati registrati in un piccolo demo, grazie all’aiuto dell’ex producer paterno Herb Cohen. Tra le quattro tracce brillavano più di tutte “Eternal Life” e quell’appassionata “Unforgiven” che avrebbe presto cambiato nome, diventando Last Goodbye.
Ma la voce e l’identità di Jeff stavano crescendo soprattutto sui piccoli palchi che lui trasformava in spazi magici. In particolare, a partire dal ’92, si affezionò a quello del
Sin-è, locale dell’East Village newyorchese . Lì, armato solo di microfono e Telecaster, Buckley Jr. era la stella del lunedì, troppo evidente per passare inosservata. Ed infatti cacciatori di talenti ed etichette accorte cominciarono ad andarlo ad ascoltare, e poi a corteggiarlo. Sarebbe stato impossibile fare altrimenti, e ce lo provano le registrazioni di quei giorni, immortalate nell’EP del ’93 “Live at Sin-è:” il sentore di grandezza si fa sempre più forte, è palpabile.
Tra le varie label pretendenti, Jeff aveva scelto la Columbia; firmato il suo primo contratto, si mise al lavoro a metà 1993 insieme ad Andy Wallace, prolifico produttore che tre anni prima aveva collaborato ad una pietra miliare come Nevermind dei Nirvana. Con l’anno nuovo l’artista abbandonò lo studio per andare in tour, proiettare la musica ancora in gestazione nella sua dimensione prediletta.
Era il 1994, il rock entrava nell’era post-grunge. Ma il 23 agosto per il rock si presentò un’ultima scintilla, esplosiva e finissima al tempo stesso. “Grace” è uno dei grandi capolavori di tutti i tempi. E’ un disco immenso che si fatica ad ammettere di debutto. Dentro ci sono decenni e tradizioni che creano qualcosa di nuovo, qualcosa di definitivo, inimitabile.
E mentre noi non possiamo che rimanere a bocca aperta, lui accosta Benjamin Britten alle sue prime composizioni, s’impossessa del grande classico di un maestro come Leonard Cohen e lo fa suo per sempre.
L”’Hallelujah “ cantata da Buckley – e collocata al 259esimo posto della classifica dei migliori brani di tutti i tempi stilata da Rolling Stone – non è più “soltanto” una grande canzone, ma un’esperienza in musica dell’anima. Jeff Buckley è padrone assoluto delle parole e della melodia, mastica emozioni e ce ne ammanta malinconicamente. E’ capace di far coesistere dolore e magnificenza, tristezza e splendore – non in alternanza, ma in straordinaria contemporaneità.
Non sono da meno i brani che portano la sua firma. “Mojo Pin” apre il disco come una carezza celeste, e poi si divide tra rabbia e preghiera. “Grace” è rivestita di un arrangiamento denso e raffinato, testimonianza di un talento naturale alla continua ricerca di preziosismi di classe.
“Last Goodbye,” col suo basso seducente e i suoi desideri tragici di meravigliosa ballata rock per molti è il pezzo definitivo, uno snodo di emozioni scottanti dipinte a fresco da corde vocali impareggiabili. E’ anche l’unico brano a far affacciare Jeff Buckley sui gradini di una classifica.
La malinconia di un classico come “Lilac Wine” lo proietta invece in un pantheon di interpreti senza tempo, come quella Nina Simone cui si stava creativamente rifacendo. “So Real” si veste di colori oscuri e procede sinistramente ipnotica, mentre il malumore languido di “Lover, You Should’ve Come Ove”r fa mostra della sua magica eredità folk distendendosi su corde sottili. La fame contaminante di un musicista come Buckley si rende più evidente che mai sulle note classiche di” Corpus Christi Caro”l, scelta nella rielaborazione di Britten come indimenticabile retaggio di una giovinezza spesa con le orecchie ben aperte. “Eternal Life” omaggia invece gli adorati Led Zeppelin, e trova in scure distorsioni le complici ideali per uno sfogo di rabbia irreparabile. L’album-capolavoro si chiude infine con “Dream Brother”: è il suono di tabla a guidare un’atmosfera incerta, quasi irreale, sulla quale Jeff tende il braccio ad un amico e tanto confida dell’abbandono paterno che lo ha segnato indelebilmente.
“Grace” ci mette un po’ a vendere, mentre si conquista da subito la meritata attenzione della critica.
Dal momento della sua pubblicazione, Jeff Buckley si dedica ad un’attività live di impressionanti dimensioni: 1994, 1995 e 1996 lo vedono costantemente in giro per il mondo, a godersi l’atmosfera intima di piccoli locali o a conquistarsi palchi prestigiosi come quello de L’Olympia di Parigi – dove nel luglio del ’95 mette in fila due serate sold-out di fronte ad un pubblico estasiato (un estratto dei concerti è stato pubblicato nel 2001 nel disco Jeff Buckley Live à l’Olympia).
Con il ’96 arriva il momento giusto per nuove canzoni, per una nuova attesissima opera; Jeff Buckley sceglie così, per il suo secondo disco, un producer d’eccezione, il leader dei Television Tom Verlaine (conosciuto tramite Patti Smith, che aveva appena ospitato Jeff nell’album Gone Again). Con Verlaine e con la band l’artista comincia a mettersi al lavoro, tra un live e l’altro, per quello che decide di intitolare “Sketches for My Sweetheart the Drunk”.
Con l’arrivo dell’anno successivo Buckley sente il bisogno d’aria nuova e decide di proseguire le registrazioni all’Easley McCain Recording Studio di Memphis. Si trasferisce così in Tennessee, e anche lì trova un piccolo palco (quello di Barrister’s) ideale all’irrobustimento dei nuovi pezzi. Si trova presto a richiamare l’ex producer Andy Wallace, e la ripresa collaborazione comincia a rendergli il nuovo materiale più soddisfacente.
I musicisti arrivano a Memphis il 29 maggio 1997. Quella stessa sera Jeff Buckley ha deciso di andare a nuotare nel Wolf River Harbor, una stanca del Mississippi, come gli è più volte capitato di fare. Con lui c’è il roadie Keith Foti, che rimane a riva ed osserva Jeff entrare in acqua – vestiti e stivali ancora addosso – mentre canticchia
“Whole Lotta Love” degli Zeppelin. Pochi attimi di distrazione per Keith al passaggio di un rimorchiatore – quando torna a guardare, Jeff è sparito.
Il suo corpo verrà ritrovato cinque giorni dopo. Le sue ultime canzoni non trovano una veste definitiva, mentre il mondo piange un talento senza pari, dalle promesse immensurabili – così violentemente spezzate.
C’è la consapevolezza di un disco che, da solo, ha già cambiato tutto; c’è l’interrogativo tragico di cos’altro avrebbe potuto succedere. Gli appunti sul futuro si lasciano leggere nella prima pubblicazione postuma, quegli Sketches for My Sweetheart the Drunk che ancora non lo soddisfacevano e che sono, improvvisamente, quello che ci resta. Meraviglie grezze eternamente in attesa
della pennellata finale. Sopra tanta bellezza incombe pesante il sentore d’incompletezza.
Con il 2016 arriva anche” You and I”, una compilation d’inediti che vede Jeff Buckley faccia a faccia con alcuni dei suoi maestri prediletti: da Dylan (sulle note di Just Like a Woman) ai Led Zeppelin di Physical Graffiti (con la scelta, da vero appassionato, dimNight Flight). Ma c’è anche Grace, splendente nella sua prima registrazione. Allora, una volta per tutte, ecco la verità: quelle firme che lo circondano – firme seminali dispiegate lungo i ’60, i ’70 e gli ’80 – non sono semplicemente firme di maestri, di ispiratori, di punti di riferimento. Sono firme di suoi pari.
Cos’hanno in comune? Un’indelebilità ancora capace di osservare le carte in tavola, gustarle fino in fondo, e poi agitarle, cambiarle per sempre.